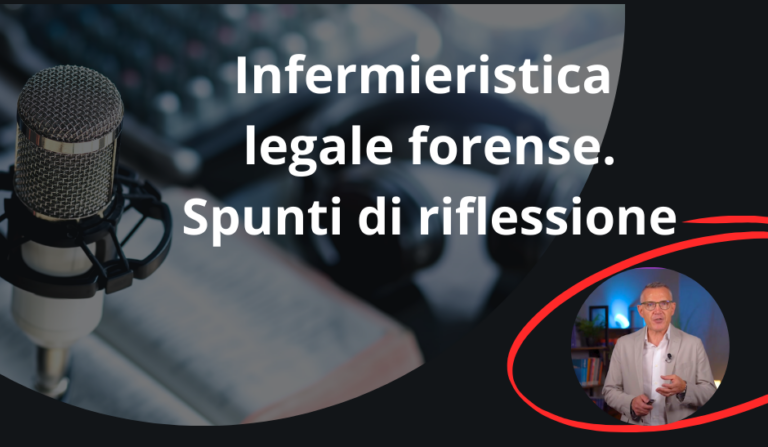Simulazione in sanità: la definizione
La simulazione è una metodologia didattica che ricrea ambienti e contesti lavorativi e relazionali simili a quelli reali per migliorare esercitare la persona ad interagire con l’ambiente, la macchina, e le altre persone.
“Nella pratica – spiega Francesco Venneri, responsabile del Centro Gestione Rischio Clinico della Regione Toscana – la simulazione permette di immaginare gli scenari più probabili ed esercitarsi ad affrontarli, siano essi interventi di laparoscopia, emergenza aereonautiche o prelievi di sangue. Importante da ricordare è la versatilità della simulazione, perché permette di migliorare sia le capacità tecniche – per esempio nell’impiego di robot e apparecchiature chirurgiche- sia le competenze non tecniche, le cosiddette soft skill: leadership, comunicazione, team work e situational awareness”.
Un esempio pratico di simulazione in sanità: impatto e riduzione del rischio
Qualche anno fa, presso l’Azienda Toscana Centro dove operavo come Risk Manager, ci erano stati segnalati comportamenti non pericolosi, ma spiacevoli e non regolari durante le emotrasfusioni. Abbiamo organizzato una due giorni di simulazioni, cercando di immaginare ogni combinazione di difficoltà. E abbiamo filmato le interazioni, ovviamente con l’autorizzazione dei partecipanti.
È emerso che gli operatori stessi, guardandosi in video, hanno iniziato a riconoscere le possibilità di miglioramento. Il risultato è stata una netta diminuzione delle segnalazioni di inappropriatezzenell’ambito delle emotrasfusioni. Presto, altri reparti si sono fatti avanti per ripetere l’esperienza. Questa buona risposta degli operatori è in linea con le indicazioni della Legge 81 che consiglia di sottoporre a valutazione le nuove procedure organizzative tramite simulazione.

Qual sono i momenti più importanti della simulazione?
Il briefing ed il de-briefing. Quest’ultimo in particolare perché, grazie al video e/o al confronto con psicologi e istruttori qualificati, si capiscono gli errori e si costruiscono assieme ai partecipanti i percorsi di miglioramento.
Come si costruisce la simulazione in sanità?
Non ci si improvvisa Istruttore di simulazione. Attualmente è necessario un Master post laurea. La simulazione stessa si divide in tre tipi: a bassa, media e alta fedeltà. La simulazione a bassa fedeltà non ha bisogno di artefatti tecnologici o meccanici (per esempio: è la simulazione di uno svenimento per strada). Quella a media fedeltà è contestualizzata in un luogo (per esempio, lo svenimento in un reparto, o in un Pronto Soccorso). La simulazione ad alta fedeltà richiede, invece, l’impiego di manichini robotizzati e la partecipazione di psicologi, di una regia e di uno istruttore.
Da quanto si impiega in sanità questo metodo formativo?
Da sempre, se si pensa alla rianimazione cardio polmonare, ma, più sistematicamente in Italia, da circa 15 anni. I pionieri della simulazione nella sanità sono stati gli psicologi cognitivi come il prof. Charles Vincent. In Italia i primi centri di simulazione sono stati a Nuoro e a Cagliari, seguiti da quelli aperti da diverse società scientifiche e, più recentemente, alcune aziende specializzate.
Ci sono tre centri in Toscana – al Meyer, Careggi e Centro Nina di Pisa legato al CNR e specializzato in patologie neonatali e della donna gravida. A Prato, infine, abbiamo una stanza per la simulazione a media e alta fedeltà – far esercitare ostetriche e ginecologi sui parti e situazioni difficili. Ostetricia, neonatologia, chirurgia e chirurgia robotica, emergenze e anestesia sono tra le discipline nella quali la simulazione viene impiegata maggiormente.
Ci sono bias nella simulazione dei quali tenere conto?
Il bias è che gli operatori conoscono a priori i parametri della simulazione perché vengono informati sugli scenari. In un caso famoso, quello del comandante Sully – che salvò passeggeri ed equipaggio atterrando nel fiume Hudson dopo aver perso l’uso di due motori simultaneamente – il risultato delle simulazioni durante il processo sembrava indicare che la scelta di ammarare fosse stata ingiustificata. C’era il tempo, diceva l’esperienza dei simulatori, di atterrare nuovamente in un aeroporto.
Nel dibattito Sully chiese si inserire il tempo della scelta che lui e il suo copilota avevano avuto: pochi secondi. L’esito della seconda simulazione fu diverso: entrambi i piloti nei simulatori precipitarono. Questa storia – conclude Venneri – ci dice che le simulazioni ci preparano alle situazioni più probabili, ma che bisogna bisogna essere consapevoli anche che non tutto può essere previsto e che l’intuizione, la decisione fulminea, il coraggio e le emozioni delle persone continueranno ad avere un ruolo anche nei contesti dove la preparazione e l’allenamento sono ai massimi livelli”.